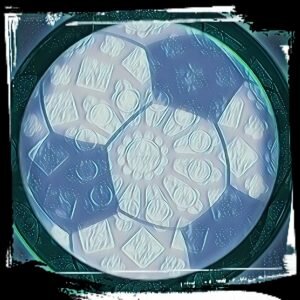Calcio e Fotografia
Il “superpotere” delle Figurine Panini
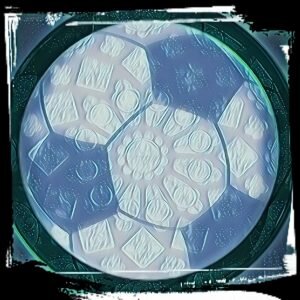
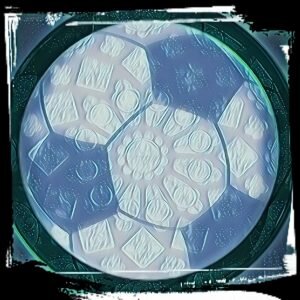
Anonimo, s.t., s.d. Abstract* Questo testo esamina il legame tra Calcio e Fotografia, focalizzandosi sul ruolo delle figurine Panini. Si riflette sul ruolo strategico delle immagini fotografiche e il loro potere di connessione con il presente e il passato. Viene descritta un'immagine iconica di Bruno Bolchi, un calciatore dell'Inter, presente nella storica tiratura delle figurine Panini. Si esplora il significato delle diverse modalità di inquadratura utilizzate nelle figurine e si evidenzia il sostegno discreto ma incisivo offerto dalla Fotografia al Calcio attraverso questi oggetti. Le figurine Panini, con la loro presenza impercettibile, contribuiscono a rafforzare il mito collettivo del Calcio, creando interdipendenze economiche e consolidando la sua popolarità globale. Un’analisi che può aprire la strada a ulteriori riflessioni sul ruolo della Fotografia nel contesto calcistico. Si delinea, inoltre, un ipotetico "Percorso Narrativo" attraverso il quale la Fotografia delle figurine Panini contribuisce al consolidamento del Calcio come sport dominante. Le figurine Panini agiscono come un mezzo meta-discorsivo, trasformando un "gioco nel gioco" in un supporto duraturo per la mitologia calcistica. Sono descritte le diverse fasi di questo percorso narrativo, evidenziando il ruolo delle figurine nel trasmettere i valori del Calcio e nel combattere potenziali avversari. La Fotografia delle figurine Panini diventa un potente strumento di supporto al Calcio, rafforzando la sua posizione dominante attraverso una rete di interazioni complessa. Il testo descrive come attraverso l'ipotetico "Percorso Narrativo" le figurine Panini e le fotografie dei calciatori contribuiscono al consolidamento e alla promozione del Calcio come sport dominante. Le figurine Panini agiscono come un supporto meta-discorsivo, trasmettendo valori e combattendo avversari rappresentando un oggetto magico con un potere difensivo. Questo percorso narrativo crea una rete di interazioni che contribuisce alla perpetuazione del Calcio come sport principale. Si riflette, quindi, sul ruolo della Fotografia, in particolare delle figurine Panini, come medium di comunicazione e come oggetto che richiede cooperazione per l’interpretazione. Si sottolinea come la Fotografia, compresa quella delle figurine Panini, sia un mezzo complesso che non può "parlare" da sola, ma necessita di un ventriloquo esterno, come una didascalia o altri media, per trasmettere significato. Si afferma che le figurine Panini rappresentano un esempio emblematico di questo processo di comunicazione mediata, con la loro natura astratta e la necessità di un'estensione di senso esterna. Si osserva che, sebbene le figurine abbiano elementi stereotipati, senza l'apporto di senso esterno rimarrebbero mute e prive di significato. Si sottolinea infine che la Fotografia, inclusa quella delle figurine Panini, richiede sempre l'importazione di senso dall'esterno per “funzionare”. Viene inoltre sottolineato il potere autentificante della Fotografia e la sua capacità di presentare il passato "al presente" attraverso l'ostensione di corpi fantasma. Il concetto di cornice viene introdotto come un delimitatore formale che protegge il significato interno dell'immagine e ne controlla il transito di senso tra interno ed esterno. Infine, si fa riferimento al potere illusorio della Fotografia e alla paradossalità della rappresentazione visiva. Nella parte successiva del testo si sottolinea il simbolismo del cerchio e della sfera come rappresentazioni del sé e della totalità della psiche umana, inclusa la connessione tra l'essere umano e la natura. Il cerchio è un simbolo che appare in varie forme di espressione umana, dalle antiche culture solari agli astronomi, dai mandala tibetani alle forme religiose moderne. Rappresenta l'aspetto essenziale e globale della vita. Inoltre, il Calcio viene descritto come una metafora della vita, con l'arbitro che ricorda il ruolo del giudice nell'assegnare sanzioni e condanne. Queste sanzioni possono essere percepite come ingiuste o eccessivamente severe, creando dispiacere. Il testo si conclude sottolineando il ruolo strategico e insostituibile della Fotografia nel contesto dinamico del Calcio, poiché permette di sintetizzare una competizione complessa in un'immagine riepilogativa, che può diventare un'icona-simbolo in grado di raccontare una serie di eventi in un singolo scatto. Ne rappresenta un esempio emblematico l'immagine che ha riassunto la vittoria della Nazionale Italiana nella Coppa del Mondo di Calcio del 2006 contro la Francia, avvenuta ai rigori dopo un pareggio nel tempo regolamentare. Buona lettura! “Se le tue foto non sono abbastanza buone, non sei abbastanza vicino” R. Capa La famosa citazione di Robert Capa che ho riportato in esergo, per quanto singolare questo possa eventualmente apparire, non l’ho propriamente ritrovata sul blog di un combattivo giornalista di “nera” o di un reporter di guerra, bensì - incidentalmente - su un sito web dedicato allo sport più popolare e praticato al mondo, ovvero il Calcio. Un sito dedicato al Calcio Femminile, per l’esattezza. Sito che ho visitato in relazione all’interesse nato dal conferimento a un familiare dell’incarico di componente del team tecnico dei preparatori atletici della nostra - per ora non particolarmente entusiasmante - Nazionale Femminile di Calcio. Una branca sportiva, quella del Calcio femminile, che sta via via superando la fase di sport di nicchia, affrancandosi progressivamente anche da tignose quanto fruste resistenze culturali del passato, non ultima, quella relativa al tradizionale monopolio maschile. Un settore, quindi, in costante e continua crescita sia per quello che concerne l’attività sportiva stessa sia riguardo alla relativa rete di riferimento. Inclusa la comunicazione, non ultima, quella veicolata attraverso la Fotografia. Ed è stata proprio una preesistente “vicinanza” a un’immagine fotografica per me particolarmente rappresentativa e la ricerca di una maggiore prossimità con quanto accennerò più avanti, che, insieme a questi primi spunti, mi ha portato a fare alcune riflessioni riguardanti talune possibili relazioni tra il Calcio e la Fotografia. Riflessioni inquinate, lo premetto, anche da ricordi personali, che, pertanto, non hanno alcuna pretesa di scientificità né, tanto meno, di esaustività. Non sono quindi rivolte a tutto il mondo del “pallone”, quanto, piuttosto, ad una frazione che ritengo comunque paradigmatica, sebbene sia soltanto un componente sussidiario che ruota nell’orbita satellitare del già accennato Pianeta maggiore, ossia il Calcio. Un’immagine, dicevo, come tante altre analoghe, confusa e dispersa nell’immenso indotto di una pratica sportiva popolarissima e, di fatto, planetaria. E, andando a ritroso nella memoria alla ricerca di quella prima, emblematica immagine e ripensando alle (non solo sue) possibili connessioni tra la Fotografia e il Calcio, ne è finalmente riemerso, via via più nitido, il relativo ricordo. Ritrovandola poi in rete e ripensando al cennato tema delle connessioni, mi sono soffermato a riflettere, innanzitutto, sul ruolo strategico di medium assunto anche da questa immagine fotografica. Una funzione di collegamento peculiare - come è, da sempre, per la Fotografia così come lo è per qualsiasi altra immagine - caratterizzata dalla proposta allo spettatore di una visione nel presente sempre rivolta “al passato”. Un “è stato”, ricordando il semiologo francese Roland Barthes, unico ed irripetibile. Per me, come per chiunque altro si trovasse a (ri)osservare anche la medesima immagine, così come qualunque altra raffigurazione. Una connessione, in ogni caso, sempre “viva” e attiva, capace, ora come allora, di stimolare emozioni e reazioni, benché, per ragioni anagrafiche, il mio sguardo e il mio interesse siano ora ovviamente diversi rispetto all’epoca del primo “contatto” con l’immagine alla quale, in particolare, faccio riferimento. Ma di quale immagine sto dunque parlando? Si tratta di un’immagine che fa parte delle memorabili serie di “calciatori” raccolte negli album delle storiche edizioni delle “Figurine Panini”, pubblicate e divenute famose sin dall’inizio degli Anni ’60. Mi riferisco, in particolare, alla prima di questa (tuttora) fortunatissima tiratura. Una scelta, lo preciso, che non è legata a ragioni di tifoseria, non essendo io, al momento, sostenitore di alcuna squadra di calcio. Premesso questo, la Figurina Panini alla quale, nello specifico, faccio riferimento è quella che ha ritratto Bruno Bolchi - detto anche “Maciste” per la sua prestanza fisica - con indosso la storica maglia dell’Inter, a bande verticali, di colore “neroazzurro”. Un calciatore, divenuto poi anche allenatore, che ha giocato a lungo nelle file dell’Inter (1954-1956 “Giovanili”, 1956-1963 “Prima squadra”), diventandone per un periodo anche il Capitano. Durante la sua militanza nella squadra ha fatto anche parte della storica formazione guidata dal “Mago” - Helenio Herrera - che, nel 1963, portò la formazione milanese alla conquista del suo ottavo “scudetto”. Un successo che, di fatto, pose le basi per la nascita di quella che, da allora, fu definita la “Grande Inter”. Erano anni nei quali i protagonisti immortalati nelle celebri Figurine Panini erano tutti rigorosamente ritratti a Mezzo busto (“MB”), ovvero ritraendone il volto a partire dal petto della persona interessata. Quella del MB è una delle tradizionali modalità di raffigurazione della figura umana, così come è stata catalogata all’interno del c.d. “piano” di ripresa. Il sostantivo piano - nella Fotografia, così come nel Cinema, ma non solo - è dunque il termine di riferimento di norma usato per indicare l’ampiezza dell’inquadratura in relazione al rapporto tra la frazione della ripresa del corpo prescelta e l’intera figura umana del protagonista ritratto. Nel caso delle citate Figurine Panini aggiungo inoltre che, a seconda dei casi, le tipologie di piano di norma scelte per effettuare le inquadrature degli atleti interessati hanno oscillato nel tempo dal summenzionato Mezzo busto iniziale - o “Mezzo primo piano” (“MPP”) - alla massima inquadratura considerata, ovvero quella che comprende la figura umana completa (“Figura intera” o“FI”). Queste due tipologie di inquadrature sono state di norma preferite rispetto ai restanti: “Piano americano” (o “PA”), nel quale il soggetto è ripreso dalle ginocchia in su; “Piano medio” o “Mezza figura” (“PM” o “MF”), nei quali l’interessato è raffigurato dalla vita in su; “Primo piano” (“PP”), nel caso in cui il volto del protagonista è inquadrato a partire dall’altezza delle spalle, come nel caso di una comune “fototessera”; “Primissimo piano” (“PPP”), quando il volto della persona ritratta è di norma compreso tra il mento e un punto vicino o poco sopra l’innesto dei capelli; un’inquadratura “cinematografica” realizzata con lo scopo di provare a far emergere - quella che Nadar, pseudonimo del celebre fotografo Gaspard-Félix Tournachon (1820 - 1910) avrebbe forse definito come - “la somiglianza intima” o, in altri termini, l’anima del soggetto ritratto; “Particolare” (“Part.”) e “Dettaglio” (“Dett.”), in tutti quei casi nei quali, con una ripresa molto ravvicinata, l’inquadratura è concentrata su di una parte del volto e/o di un’altra parte del corpo dell’interessato, come, ad esempio, avviene durante le riprese televisive di una qualsiasi partita di calcio, allorché, per descrivere una particolare azione e/o un eventuale infortunio, la camera “stringe” sul dettaglio del corpo dei calciatori di volta in volta interessati. Aggiungo infine, per completezza, che qualora l’inquadratura fosse, invece, molto più ampia della “FI” - come nel caso della classica inquadratura raffigurante un’intera squadra di calciatori - potremmo trovarci di fronte ad un’ulteriore livello, con l’eventuale passaggio dal ridetto piano, in una delle varianti appena illustrate, al c.d. “campo” (di ripresa). Una griglia di opzioni ben definite, dunque, funzionali, innanzitutto “a coprire” quella dimensione documentaria che, nell’immaginario comune, è di norma assolta da qualsiasi istantanea. “La” Fotografia tout court, secondo un comune sentire. Un’immagine particolarmente rappresentativa, quella di Bruno Bolchi, che richiama subito l’attenzione sull’efficacia del sostegno, anche indiretto, offerto sin dagli albori (non solo) dalla Fotografia al Calcio. Un sostegno discreto, in particolare, quello delle Figurine Panini, tanto impercettibile, quanto incisivo, non ultimo, proprio grazie a questa sua apparente invisibilità. Un “rinforzo”, che, con altri media, la Fotografia contribuisce costantemente ad alimentare potenziando quel mito collettivo che è ormai universalmente divenuto il gioco del Calcio. Un mito crescente, inossidabile, che avvolge e coinvolge, inarrestabile, l’intero globo terracqueo. Un mito che attrae sistematicamente audience sempre considerevoli, creando, in tal modo, interdipendenze economiche con numeri da capogiro, che lascio volentieri ad altri analisti sicuramente più competenti. Un mito apparentemente immune e, non di rado (eccezion fatta per la pandemia Covid-19), finanche “indifferente” e, pertanto, inarrestabile di fronte a qualsiasi altro evento, anche di grande portata e/o forza simbolica che possa eventualmente incrociare sulla sua strada. Sia esso interno (si pensi, ad esempio, ai periodici scandali legati alla compravendita degli atleti, alle scommesse, ai diritti televisivi, etc.) sia esterno (ricordo, in particolare, l’attacco alle Torri Gemelle e, non ultimo, il recente conflitto in corso proprio nel cuore della nostra cara e ormai sempre meno “solida” e sicura Vecchia Europa). Ma, lasciando ad altri anche gli aspetti concernenti eventuali questioni di geopolitica e tornando alle Figurine Panini, proverò ora a tratteggiare brevemente le modalità narrative attraverso le quali secondo me la Fotografia, con e/o senza altri media, contribuisce a consolidare la mitologia quotidiana e sempreverde di questa popolare pratica sportiva planetaria proprio attraverso le cennate Figurine Panini. Tra queste, facendo riferimento al noto “Percorso Generativo del senso” a suo tempo descritto da A. J. Greimas e J. Courtés, provo ora a delineare (seppur sommariamente e parzialmente) un ipotetico “Percorso Narrativo” (“PN”) attraverso il quale la Fotografia, in particolare quella veicolata dalle Figurine Panini, concretizzerebbe il suo strategico, quanto determinante contributo al consolidamento del primato del Calcio anche alimentandone la relativa mitologia. Un contributo anche di tipo meta-discorsivo, quello delle Figurine Panini, capace di condensare e trasformare - anche attraverso una costante autoanalisi critica – una sorta di “gioco nel gioco” nella determinante e duratura forma di sostegno e “rinforzo” accennata poc’anzi. Una risorsa forse non fondamentale, quella delle Figurine Panini, ma, a mio parere, comunque, importante, come detto, per il suo contributo, unitamente ad altri media, a sostegno della costante primazia del mito del Calcio. Una cooperazione sinergica che, strategicamente, contribuisce nel contempo anche a “preparare” i potenziali target futuri, stimolandone e alimentandone progressivamente fin dalla Prima infanzia il relativo interesse. Un interesse spronato attraverso una pratica ludica - affatto disinteressata - apparentemente innocua che, proprio in quanto tale, non trova di norma “resistenze” sia nei cennati target potenziali sia nei relativi gruppi di pari, familiari e/o educativi di riferimento. Lo fa all’interno di un PN articolato su più livelli e dotato anche di un vero e proprio impianto gerarchico. In questo scenario a più piani, le Figurine Panini “traducono” e portano dal fondo sino “in superficie” il relativo sistema di valori posto “alla base” della narrazione. In questa struttura organizzativa, immediatamente sopra i valori di fondo, ma sempre “sotto la superficie” delle apparenze formali, troviamo i relativi “attanti”. Questi ultimi emergono infine “in superficie” e, venendo “a galla” assumono finalmente una veste anche formale. Vengono, infatti, “tradotti” nelle relative figure formali, ovvero, nel caso delle celebri Figurine Panini nella miriade di calciatori di volta in volta raffigurati. Protagonisti e, insieme, testimonial della ridetta narrazione originaria. Sono loro, dunque, gli attori “veri”, ossia quelli visibili sui milioni di Figurine Panini impresse ogni anno. Le mitiche Figurine che molti di noi hanno conosciuto, comprato, scambiato e a lungo anche collezionato, a partire dalla numero uno, ovvero quella nella quale è stato ritratto il più volte detto Bruno Bolchi. E, così facendo, sin dall’inizio, attraverso queste “protesi” (affettive, culturali, etc.), viene tuttora sostenuto e continuamente rivalorizzato ulteriormente il patrimonio di senso e di valori condensato “a monte” di ciascuna delle fotografie raffiguranti da decenni i calciatori delle Figurine Panini, sostenendo e promovendo incessantemente “a valle” questo sport e consolidandone nel tempo il relativo inscalfibile primato. Una “battaglia” silenziosa nei confronti di altri eventuali avversari, quale un qualsiasi altro sport “minore”, che vede contrapporsi asimmetricamente questo colosso economico, organizzativo, culturale, etc. sostanzialmente a dei soggetti di norma sempre più deboli. Una dialettica impari (non solo) tra attanti, che, convenzionalmente, gli studi di semiotica hanno condensato nelle classiche figure contrapposte di “Eroe” e “Antieroe”. Nell’ambito di questa squilibratissima contrapposizione dialettica, la Fotografia - per il tramite dei calciatori ritratti – riveste, per quanto ovvio, i panni dell’Eroe, sostenendo ulteriormente la causa del Calcio e, nel contempo, “combattendo”, anche indirettamente, l’Antieroe di turno. Ad esempio, un altro sport in competizione per tentare di riposizionarsi meglio sul mercato, tentando almeno di intaccare il tradizionale ed inossidabile primato del Calcio. Forze ostili che si “incarnano” in altri attanti/attori, Antieroi, ovvero il nemico per definizione. La trasposizione pratica ed operativa di questo schematico impianto teorico è incarnata dal reticolo di interrelazioni animato dalle Figurine Panini che tutti più o meno direttamente o indirettamente abbiamo eventualmente sperimentato anche in prima persona. Miriadi di micro eventi, pressoché continui, connessi con le diverse transazioni via via effettuate. Un articolato reticolo narrativo principale popolato e animato dalle tantissime, minute narrazioni secondarie alimentate da altrettanti protagonisti, giovani (ma non solo), comparse di un mercato sempre molto dinamico e vivace, fatto di innumerevoli: acquisti, vendite, scambi, raccolte, etc. Una rete di interessi vastissima, dunque, che ruota da sempre intorno alle ridette Figurine Panini. Figurine che la semiotica può quindi, indiscutibilmente, configurare come un autentico “Oggetto di valore”. Un Oggetto del desiderio comunque non primario, se posto in relazione, in questa sorta di scenario “bellico”, con la sopravvivenza del Pianeta maggiore, ovvero del Sistema Calcio (complessivamente inteso). Una sorta di entità ombrello, che in questa intricata rete di relazioni, riveste il ruolo di vero e proprio “Mandante/Destinante” incaricando l’attante di turno, ovvero, nel nostro caso, l’Eroe da Bruno Bolchi e tutti gli altri epigoni. O meglio, per l’esattezza, dal suo fantasma, dal suo riflesso nella “sua” Fotografia (militante nelle file dell’esercito delle Figurine Panini). Un idolo comunque incaricato di dare fino in fondo il proprio contributo per portare a termine la missione destinatagli. Un’entità multidimensionale, quella del Calcio, composta e animata, come accennavo, da valori di fondo, attanti e attori formali diversi, tra loro interrelati da un altrettanto variegato reticolo di relazioni anche non sempre reciproche e simmetriche. In una prospettiva semiotico-narrativa, questo caos interno potrebbe rappresentare un ulteriore e temibile elemento avverso. Se non proprio “il” potenziale disequilibrio iniziale di un sistema di potere dai tratti ormai ipertrofici. Questo disequilibrio relazionale, piuttosto che la ripetuta salvaguardia della primazia del Calcio a discapito degli altri sport potrebbe dunque rappresentare uno dei possibili “inneschi” per il conferimento dell’incarico di Eroe all’esercito di calciatori-difensori che da decenni, a milioni, “ci guardano” dalle Figurine Panini. Un incarico volto a dissolvere o, quanto meno, a contenere, per quanto possibile e in modo duraturo, sia minacce contingenti, comunque temibili, sia quelle persistenti e ancor più nefaste per il Mandante, ovvero la ridetta perdita della primazia di sport più praticato al mondo rispetto a tutti gli altri. Quel Mandante, che, come detto, affida dunque all’attante/Fotografia “incarnata” nei ritratti contenuti nelle Figurine Panini il ruolo di Eroe, affinché sconfigga qualsiasi possibile Antieroe antagonista. Chiunque esso sia. Ovunque esso sia. E, perché la Fotografia - nel ruolo di Soggetto operante - possa concretamente riuscire nel suo intento, il Mandante verifica prioritariamente il possesso di quelle che la grammatica generativa ha definito come le competenze atte a svolgere l’incarico. Dotandolo poi, se del caso, anche un “adiuvante magico”, ossia di una sorta di “strumento magico”. Uno strumento magico che, anche nel caso delle Figurine Panini, è condensato nello “sguardo di Medusa” che ciascuna delle immagini fotografiche degli atleti ritratti comunque possiede. Detto diversamente, lo strumento magico dato in dotazione è, in realtà, … la “forza paralizzante” insita nella Fotografia stessa. Un’immagine, dunque, un simulacro del “reale”, null’altro che uno spettro dotato, però, di una sorta di “superpotere”. Un cruciale elemento difensivo, perché da esso potrebbe anche dipendere il buon esito dell’incarico originariamente affidatogli dal Mandante. Immagini, come altre, in fondo, quelle contenute nelle Figurine Panini. Un esempio rappresentativo del “corpo” multiforme, pluridimensionale, poliedrico, plurale e, non ultimo, a più livelli e statuti della Fotografia. Fotografia che, di volta in volta, raffigura comunque un referente ormai inesistente che, tuttavia, si “rimaterializza”, per l’occasione, in una sorta di miracolo del doppio. Un simulacro visivo, si è detto. Un idolo originariamente “esalato” dal (s)oggetto all’atto della ripresa. Usando le parole del già citato semiologo francese Roland Barthes, in ogni immagine fotografica si concretizza una sorta di … “ritorno del morto”. Attraverso la trasformazione, l’imbalsamazione virtuale compiuta ogni volta dalla Fotografia, si “sperimenta” quella che lo studioso transalpino ha definito come “una micro-esperienza della morte”. Un interludio nel corso del quale il ritratto diviene effettivamente uno spettro Una parentesi nel corso della quale chi vi è ritratto non è né un oggetto né un soggetto, ma, piuttosto, un soggetto che sta “evolvendo” in un oggetto. Oggetto che, nel caso in discorso, è rappresentato da ciascuna delle cennate Figurine Panini. La Fotografia, nella fattispecie delle Figurine in discorso, grazie alla mutazione appena accennata risulterebbe, quindi, un (s)oggetto particolarmente idoneo allo scopo. Un soggetto operante multi-dotato e, quindi, a sua volta particolarmente insidioso per il fronte nemico. Un soggetto capace di dimostrarsi molto insidioso, non ultimo, proprio a partire da un suo apparente difetto immanente, che la connota da sempre, ovvero per la sua indeterminatezza. Indeterminatezza che la contraddistingue in fase di ricezione rendendola una sorta di “segno selvaggio” ogni volta difficile da interpretare, nonostante l’ingannevole apparente semplicità con la quale la Fotografia da sempre si presenta. Un segno selvaggio, da decodificare e reinterpretare, in ogni caso, ad ogni nuova visione, finanche della medesima immagine, attingendo senso e valore, sempre e comunque, prevalentemente da “fuori”. Un percorso interpretativo, pertanto, sempre diverso e, in fondo, “personalizzato” per ciascun destinatario. La natura “selvatica” - di questo prototipo dei maggiori media moderni - innesca dunque, ad ogni nuovo sguardo, un’incessante, ulteriore risemantizzazione del “reale”. Una risemantizzazione che, nel caso del Calcio (ma non solo, ovviamente), sarà necessariamente caratterizzata da una lettura per quanto possibile “piegata” e funzionale al suo mandato di Mandante originario. Ruolo che la Fotografia assolve e intermedia da sempre, distinguendosi e conservando un ruolo tuttora di primo piano, seppure in un costante, quanto ineludibile confronto dialettico anche con altri, altrettanto agguerriti media (penso, in particolare, alla tv). Ruolo strategico che, anche oggigiorno, continua a difendere anche nella sua versione numerica così come ha già a lungo fatto, in passato, nella sua forma analogica tradizionale. E, nonostante abbia affrontato e attraversato un guado tecnologico così particolare ed epocale, la Fotografia è risultata comunque sempre in grado di conservare le sue potenzialità comunicative originarie. Persino rafforzandole. Tra i tanti possibili, anche alla luce di quanto detto sinora, le Figurine Panini ne condensano un esempio concreto emblematico e ben rappresentativo. Tra le altre, la sua costante caratteristica di medium onnipresente, la cui modalità di utilizzo più diffusa non è di norma quella più “alta”, magari collegata a una dimensione autoriale, cultuale e auratica, bensì quella quotidiana, molto più “bassa”, sostanzialmente di massa, fatta di brandelli visivi, di frazioni visuali, di schegge riflettenti, ovunque disperse in una pratica di consumo minuto e interstiziale, globale e ormai, sostanzialmente, universale. Una prospettiva che, non a caso, sembra corrispondere anche con l’identikit delle Figurine Panini. Un profilo che le identifica come potenziali avanguardie di un percorso comunicativo interstiziale di promozione e sostegno del disegno del Mandante/Destinante per il radicamento del mito del Calcio fin dalla Prima infanzia, con tutta una serie di richiami e di “rinforzi” successivi che - in sinergia con altri fattori e altri media - concorrono al consolidamento nell’immaginario collettivo della ridetta primazia del Calcio rispetto ad altre discipline sportive. Un’avanguardia particolarmente incisiva ed efficace nella sua azione, perché, al pari di un “Cavallo di Troia”, ha già da tempo “bucato” le eventuali (scarse) difese del destinatario interessato, “rinforzando”, sin dall’infanzia, solide basi di interesse per questo sport. Ad esempio, disseminando nel target interessato delle “spore” che, al verificarsi di determinate circostanze favorevoli future, potrebbero automaticamente riattivarsi rinnovando, magari in maniera anche crescente, un eventuale interesse nei destinatari per questa branca sportiva, ma non solo. Una sorta di gratificante coazione a ripetere, come ci hanno più volte illustrato gli specifici studi di settore. Detto questo, mi preme precisare che, per quanto ovvio, questo mio sommario e semplificatorio excursus, a tratti persino meccanicistico e deterministico, non intende affatto escludere tutta una serie di altri fattori - culturali, ambientali, tecnologici, etc. - che, in maniera di volta in volta anche molto differente, potrebbero “agire” sul soggetto interessato, con esiti che, anche in casi apparentemente analoghi, potrebbero portare a risultati finanche diametralmente opposti. A questi primi, sommari riferimenti all’ambito semiotico-narrativo, aggiungo ora anche quello relativo, in particolare, all’Arte concettuale. Una dimensione che mi sembra rintracciabile anche nelle mitiche Figurine Panini oggetto di questo testo. Infatti, come qualsiasi altra immagine, anche le Figurine Panini, sia nel caso che vi risultino ritratti singoli atleti sia intere formazioni si configurano, in ogni caso, come delle forme di astrazione. Altrimenti detto, come una sorta di opere concettuali. Astrazioni, dunque, media “bizzarri”, come li definirebbe il citato critico francese R. Barthes, che fanno circolare “messaggi senza codice”, mostrando una realtà comunque “intrattabile”. La loro bizzarria non gli permette comunque di “parlare” senza l’aiuto di un “ventriloquo”, ovvero senza una “voce esterna”. Un altro medium, quindi. Come, ad esempio, un’apparentemente innocua e neutra didascalia esplicativa. Una condizione assurda, di mutismo, che solo un ventriloquo che “parli” al posto dell’immagine fotografica - importando senso di norma dall’esterno e incollandolo “dentro” l’immagine - le permette poi di “parlare”. E, così facendo, magari svelarci riferimenti utili riguardo ai singoli, piuttosto che ai gruppi eventualmente raffigurati in un’immagine. Quali: la squadra di appartenenza, il relativo percorso professionale, i team interessati, la loro storia, etc. La Fotografia tutta - inclusa quella veicolata dalla Figurine Panini - è dunque un apparato (non solo tecnico) complesso e articolato che, come il corpo umano, esiste e funziona, solo grazie - e attraverso - altri “corpi-organi”, ovvero per mezzo di altri media. Organi di norma “interni”, nel caso del corpo umano. Organi di norma “esterni”, ovvero altri media non contenuti “dentro” l’immagine, invece, nel caso della Fotografia. Elementi esogeni di senso, che concorrono dall’esterno a “dare una forma” e una “voce” ad ogni immagine fotografica. Un’immagine che vive, dunque, proprio attraverso l’intermediazione della ventriloquia mutuata da altri media. E non c’è alternativa per qualunque tipo di immagine, comprese le Figurine Panini, per uscire dal loro mutismo congenito, se non ricorrere, come accennato, all’aiuto “esterno” di altri media. Nella “casa di vetro” della Fotografia, “dentro” ogni immagine, in sostanza, non c’è di norma nulla, se non si importa del senso dall’esterno. Tutto o quasi quel senso, la narrazione, i valori, etc., arrivano di solito da un’altra parte, posta fuori dall’immagine. Un altrove, un “fuori”, che, di norma, è dunque tecnicamente estraneo all’immagine. E le Figurine Panini, come dicevo, non fanno, ovviamente, eccezione. Anzi, ne sono proprio una conferma e una rappresentazione emblematica. Attraverso le “pareti” apparentemente trasparenti di qualsiasi fotografia noi crediamo, infatti, di “guardare dentro” l’immagine. Ma, in realtà, quel che osserviamo, non è l’interno ma quello che, dall’esterno, viene riflesso all’interno. Altrimenti detto, anche il “corpo” di una qualsiasi Figurina Panini, come qualunque altra immagine del resto, è un corpo muto, senza parola e senza un senso predefinito. Sin dalla “nascita”! E può “parlare”, come si è accennato, non con la propria “voce”, bensì soltanto per mezzo di una protesi significante esterna trasfusa dentro l’immagine da un contesto terzo, estraneo all’immagine e posto, come detto, “fuori” dalla fotografia. A voler essere rigorosi, forse, almeno parzialmente, le Figurine Panini potrebbero eventualmente rappresentare una parziale eccezione, caratterizzate, come sembrano essere da sempre, da elementi di forma fortemente stereotipati, a partire dalla posa, dalle divise indossate, dalla presenza di altri simboli (quali: effigi, scudetti, etc.). Tuttavia, in assenza di aiuti esterni, senza un senso esterno decodificabile “incollato” dentro l’immagine fotografica di volta in volta interessata - per quanto stereotipato possa essere questo significato importato “dentro” - anche questo tipo di immagini (persino dei veri e propri cliché) rimarrebbero, in ogni caso, sostanzialmente mute. Senza questo aiuto esterno, non sapremmo, ad esempio, quando, dove e perché sia stata mai realizzata una certa immagine. Ma non solo, non potremmo neanche dare un nome agli eventuali (s)oggetti ritratti al suo interno. Non potremmo quindi dare - al pari di un medico legale impegnato nell’esame post mortem di una salma - nessun dato neanche riguardo alle possibili “cause” dell’evento rappresentato nell’immagine, né, tantomeno, dei corpi ancora anonimi raffigurati “dentro” l’immagine stessa. La Fotografia, quindi, solo dopo essere stata rifornita adeguatamente di senso importato dall’esterno, diviene quella che tutti conosciamo, ovvero uno strumento e un canale di comunicazione capace di dare finalmente “voce” ai (s)oggetti presenti al suo interno. Altrimenti tutti comunque accomunati, senza la ridetta “assistenza esterna”, da una originaria “consegna del silenzio”. Una “consegna” alla quale, ovviamente, non sfuggono neanche immagini fortemente stereotipate, quali le Figurine Panini. E di fronte a tanto mutismo, d’innanzi ad un silenzio così “assordante” non è conseguentemente possibile comprendere di fronte a chi e/o che tipo di rappresentazione ci si trovi. All’opposto, invece, con il sostegno simbolico di altri media - sia testi scritti (quali, ad esempio: appunti, legende esplicative, etc.) sia testi non scritti (altre immagini, testimonianze audiovisive, descrizioni orali, etc.) - ogni tentativo di “lettura” dell’immagine, prima condannato ad un esito incerto se non persino fallimentare, assume poi una connotazione di senso più o meno definita e, comunque, ben diversa dal mutismo precedente. Si è di fronte ad un’immagine finalmente “parlante” perché non più orfana di senso. Diviene quindi possibile farne anche un’eventuale ricostruzione indiziaria, una sorta di “autopsia” più attendibile del “cadavere” che si sta osservando. Si può, in tal modo, “dare voce”, ad esempio, anche: ai luoghi fisici raffigurati, al senso delle posture delle varie comparse, all’umore generale di un evento documentato e, non ultimo, agli stessi protagonisti ritratti. Tra questi “aiuti”, si pensi, come già accennato. in particolare alla potenza espressiva, alla forza d’urto semantico, di norma inavvertita, di una piccola e apparentemente semplice didascalia. Un testo che è quanto mai strategico per la sua determinante funzione di staffetta, di orientamento e ancoraggio semantico dell’interpretazione entro confini più o meno definiti. Ci si potrebbe infine forse chiedere, giunti a questo punto, pur correndo il rischio di alimentare qualche sospetto per una sorta di eccesso di relativismo, se anche le Figurine Panini:
Le Figurine Panini sono quindi anch’esse emblematici quanto trasversali surrogati prodotti dalla Fotografia. Supplenti di altrettanti corpi che con la Fotografia generalmente intesa, hanno uno strategico elemento in comune, ovvero: la cornice.
Un ulteriore corpo significante, un delimitatore formale del perimetro “politico” d’interesse, anche quando non sia chiaramente delineata, risulti indefinita e poco o per nulla tangibile. La cornice incarna sostanzialmente il reticolato, il muro di cinta - i confini reali o immaginari - posti a presidio, controllo e difesa del contenuto di senso interno all’immagine. Essa è il regno della liminalità, una sorta di frontiera “sorvegliata” dove viene controllato ogni transito di senso tra l’esterno e l’interno dell’immagine e viceversa. Un varco, un limbo liminale e, insieme, un ponte fra due o più dimensioni di senso e la relazione dialettica tra l’interno dell’immagine con quanto è e veicola significato e valori al di fuori di essa. Una dialettica e una contrapposizione ineliminabili, incessante, ininterrotta e, in ogni caso, strategici per assicurare l’intangibilità del senso acquisito protempore. Almeno “sino a nuovo ordine”, come, ad esempio, nel caso di un’eventuale risemantizzazione parziale o totale del senso contenuto nell’immagine interessata, incluse le Figurine Panini.
Una interrelazione strategica, quindi, perché, senza di essa, l’interno dell’immagine non potrebbe avere né senso “certo”, così come, all’opposto, l’esterno non potrebbe, ad esempio, confermare e consolidare la relativa dimensione significante. Un senso che si nutre, si arricchisce e si consolida vicendevolmente, proprio grazie alla relazione tra ciò appare essere “dentro” e ciò che è “fuori”. Un confronto dialettico tra elementi diversi, divisi da quel limen, quel confine di norma rappresentato, come accennavo poc’anzi, dalla cornice. Dimensioni diverse, comunque sempre interrelate, sebbene con gradienti, contenuti, valori e in una relazione sinergica di volta in volta eventualmente anche variabile, che, in ogni caso, contribuiscono a definire il relativo scarto di senso, la relazione gerarchica e funzionale, etc. tra ciò che, sottolineo, è “dentro” e ciò che è “fuori”. Ė questo, in linea teorica, il contenuto di senso che custodisce e difende nei suoi confini, nel suo perimetro - formale o, talora, anche soltanto immaginario e/o ipotetico - una cornice.
Le Figurine Panini, analogamente a qualsiasi altra immagine, lo ribadisco, non fanno ovviamente eccezione.
Così come, anche per Figurine Panini, vale la riflessione generale, anch’essa di R. Barthes, che evidenzia come una delle caratteristiche distintive della Fotografia sia il suo potere di autentificazione. Un potere di autentificazione che mette in subordine quello di raffigurazione. Raffigurazione attraverso la quale la Fotografia “registra” a suo modo l’essenza visiva del mondo. Un’essenza visiva che, per quanto differita a livello temporale, supera la mera riproduzione del reale, andando oltre. Un andare oltre che ripropone il passato presentandolo addirittura “al presente”. La Fotografia diviene, in tale prospettiva, una specie di fabbrica degli spettri, producendo ininterrottamente soltanto una sorta di corpi fantasma.
Corpi fantasma paradossalmente immersi in un eterno presente fittizio.
Un presente ipotetico, dunque, quanto immutabile e senza futuro, del quale la Fotografia ci mostra perennemente il “cadavere” del corpo del relativo referente originario.
Attraverso questa ostensione nella “camera ardente” simbolizzata in ogni immagine, la Fotografia alimenta l’emergere di una dimensione straniante, dove il “reale” è sempre assente. Un “reale” scomparso e sostituito soltanto da simulacri visivi. Una specie di follia percettiva, una vera e propria allucinazione visiva che – attraverso questo medium “folle” che chiamiamo Fotografia – offre allo sguardo “corpi” ormai svaniti, virtualmente reificati e resi presenti… “al passato”.
Ne deriva, ha sintetizzato ancora R. Barthes, che:
“La Fotografia diventa allora […] medium bizzarro, una nuova forma di allucinazione: falsa a livello della percezione, vera a livello del tempo.”
Ogni immagine, inoltre, è per sua natura sempre una paradossale rappresentazione di secondo grado che, nella migliore delle ipotesi, può far presupporre – senza comunque poterlo garantire con certezza assoluta – un eventuale rapporto con un altrettanto eventuale referente originario, una possibile fonte concreta, “reale”.
Un collegamento, una relazione ipotetica, dunque, tra un prima e un dopo, tra un originale e una sua probabile copia, che, inevitabilmente, sfocia in una paradossalità. Una paradossalità generata dalla coesistenza nell’immagine-copia, come emblematicamente avviene in tutta la Fotografia, di un (s)oggetto comunque altro, differente dall’originale, seppure nell’apparentemente indistruttibile vincolo di verosimiglianza con l’analogo originario. Un’assurdità insita in ogni immagine - Figurine Panini comprese, ovviamente - proprio a causa dall’amalgama in ciascuna di esse di un’immagine altra, diversa e comunque anche temporalmente più o meno distante, del suo apparente (s)oggetto originario.
L’idea diffusa della verità come presunta somiglianza fedele tra una rappresentazione e il suo referente, forse in nessun ambito è così tanto pregnante e insistente come nel mondo delle immagini.
Nella Fotografia, considerata “il” vero ed inossidabile “duplicato” del reale, sembra poi riecheggiare in maniera ancor più evidente perché non offre, in assoluto, alcuna risposta definitiva che dia una certezza assoluta. Questa indeterminatezza è ovviamente ulteriormente amplificata nel caso di immagini che hanno l’eventuale “sfortuna” aggiunta di non riprodurre fedelmente le apparenze del relativo referente originario. Del resto, se così fosse, ovvero se l’immagine fosse la copia esatta del suo originale, non esisterebbe alcuno “scarto” tra la copia e l’originale e non vi sarebbe più alcuna differenza tra di loro.
Un vincolo che vale, ancora una volta, anche per le Figurine Panini.
Figurine Panini, che, come altri “satelliti” orbitanti nel sistema solare calcistico, gravitano incessantemente intorno a quell’immenso “corpo attraente” che è stato, è e rimarrà il pallone.
Un oggetto che, al di là delle sue caratteristiche materiali e formali è, nel contempo, anche un elemento carico di valenze simboliche, in particolare per il suo naturale rinvio alle figure geometriche del cerchio e della sfera.
Come oggetto, la figura geometrica di riferimento - approssimandosi a quella della sfera - è quella dell’icosaedro troncato, il poliedro regolare che ha il maggior numero di facce. Si tratta di un solido semi-regolare, composto da pentagoni ed esagoni cuciti e/o uniti tra di loro, che ha complessivamente 32 facce: 12 delle quali pentagonali, di norma colorate di nero, e le altre 20 facce esagonali, generalmente colorate di bianco. Un modello che era venuto in mente già ad Archimede, il quale, nel III secolo a.C., indicò l’esistenza di 13 solidi semi-regolari, che furono conseguentemente definiti: “archimedei”.
A livello simbolico il cerchio e/o la sfera costituiscono da sempre anche un simbolo del sé. Più nello specifico, rinviano alla totalità della psiche in tutti i suoi aspetti, comprendendo, in tale prospettiva, il rapporto fra l’essere umano e la Natura, complessivamente intesa. Di conseguenza, il simbolo del cerchio, che si sia manifestato nei culti primitivi dedicati al culto del Sole, piuttosto che nelle riflessioni dei primi astronomi, in un mandala tibetano, così come nelle forme “religiose” della modernità - con l’eventuale applicazione delle sue forme nella pianificazione urbanistica metropolitana, piuttosto che nell’arredo di un luogo di culto, come nel caso dei c.d. “rosoni” - ha sempre evocato l’aspetto essenziale della vita, la sua complessiva globalità.
Il Calcio, inoltre, si connota, da sempre, anche come una popolare metafora della vita o viceversa.
Per fare soltanto un esempio, suggerirei di pensare, in particolare, alla figura dell’arbitro. Un ruolo che, anche andando oltre la dimensione metaforica, rimanda comunque a quello del giudice nell’attribuzione di eventuali sanzioni e/o di condanne: calci di punizione e/o di rigore, ammonizioni, espulsioni, etc. Sanzioni, che, per i possibili esiti, possono talora risultare tanto indigeste non solo per l’eventuale danno che possono determinare “a valle” nell’immediato, quanto risultare particolarmente odiose, come nel caso in cui possano essere magari ritenute eccessivamente severe, sproporzionate, se non, addirittura, finanche errate e/o “volute”, etc.
Ma, tornando un’ultima volta alle relazioni tra il Calcio e la Fotografia, concludo ricordando che, pur nel diluvio ininterrotto di output visivi che ci sommerge quotidianamente, quest’ultima si dimostra, ancora una volta, strategica e, di fatto, insostituibile. In particolare, in contesti articolati e dinamici come quello del Calcio, con tutto il suo fitto reticolo di eventi, “settimanalizzazioni” delle notizie, etc. L’esigenza “fisiologica” e imprescindibile di sintetizzare una competizione complessa in un’unica – magari storica - immagine riepilogativa rende, infatti, la Fotografia uno strumento ineguagliabile in termini di efficacia e di incisività. Il singolo fotogramma, può divenire quindi una sorta di icona-simbolo, in grado di condensare in sé la narrazione di un’intera serie di eventi in un singolo, emblematico “scatto” riassuntivo. Si pensi, per fare un ultimissimo esempio tra i tanti possibili, al fermo-immagine che ha “riepilogato” l’esito dell’ultima Coppa del Mondo di Calcio della Nazionale Italiana, con la vittoria “ai rigori” (5-3) contro la Francia, al termine dell’incontro, svoltosi a Berlino il 9 luglio 2006 e precedentemente conclusosi in parità (1-1).
Roma, 15 agosto 2022
G. Regnani
Per la redazione di questo testo indico alcuni dei riferimenti bibliografici:
Barthes R., La camera chiara. Nota sulla fotografia, Einaudi, Torino, 1980.
Fabbri P., Marrone G., Semiotica in nuce I, Meltemi, Roma, 1999
Fabbri P., Marrone G., Semiotica in nuce II, Meltemi, Roma, 1999
Fiorentino G., Il valore del silenzio, Meltemi, Roma, 2003.
Floch J. M., Forme dell'impronta, Segnature, Paris, 2003.
Flusser V., Per una filosofia della Fotografia, Torino, Agorà Editrice, 1987
Jung C.G., L’uomo e i suoi simboli, Longanesi, Milano, 1991
Sontag S., Davanti al dolore degli altri, Mondadori, Milano, 2003
Wunenburger J.-J., Filosofia delle immagini, Einaudi, Torino, 1999.
--------
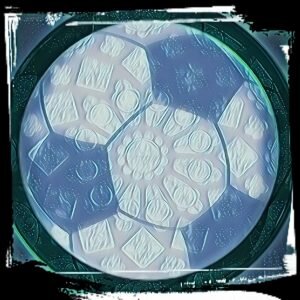
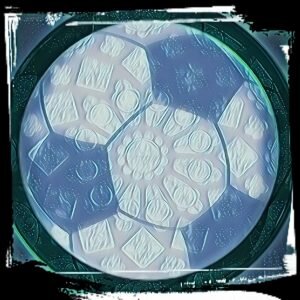
*Assistenza: Chat GPT Open AI